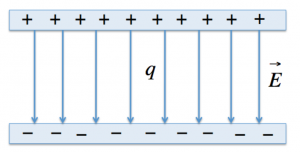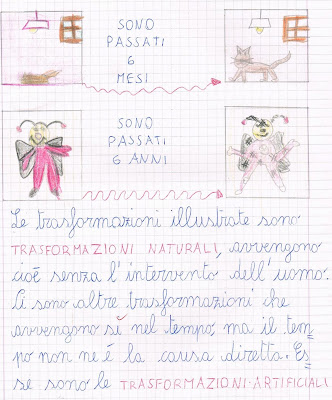di Fabio Stassi
Per anni mi sono imbattuto nella Coscienza come in un vecchio amico che si incontra per strada: poche parole, un rapido mulinellare di pagine sulle dita, e l’affetto e il disagio che sempre danno i ricordi dell’adolescenza. Più spesso ho fatto finta di non vederla: correvo avanti sugli stessi scaffali in cerca di un altro volume, la evitavo. Certo che non valeva la pena sapere che ne era stato, se poi ne avevo davvero intuito qualcosa, da ragazzo. È il destino dei libri che si studiano a scuola e che si crede di conoscere. Per riaprirli ci vogliono altri occhi, fatti più aspri, e nessun commercio di voti. Ma della Coscienza non ne avevo mai smesso la curiosità, l’avevo soltanto rimandata. Ci eravamo dati un appuntamento, con quel libro. Per quando avrei dimenticato le formule dei manuali e le storie letterarie. A quell’appuntamento ci sono arrivato in ritardo, con un principio di canizie e una miopia di tutto, senza sapere che tornavo a leggere un romanzo sconosciuto.
Zeno lo ricordavo il campione dell’inettitudine per eccellenza, il paradigma dell’inabile e dell’incapace. Cesare Musatti riassumeva così la nozione canonica della personalità di Zeno:
Un individuo sempre indeciso, che non conclude gli studi, che vive da parassita, che ha aspirazioni musicali ma fallisce anche in questo campo, che non possiede amici veri, che si comporta in modo gretto con le donne, che nel suo egoismo non ha affetto per alcuno, che anche quando, durante la guerra, deve provvedere da solo a se stesso, arricchisce, sì, ma soltanto in virtù della disponibilità di denaro e di un meccanismo economico che non riesce affatto a comprendere, tanto che al primo variare della situazione perde tutto ciò che aveva grossolanamente accumulato: un individuo da definirsi sul piano psicoanalitico non genitalmente maturo e che, come egli stesso dice, fa sempre centro, non tuttavia sul proprio bersaglio, bensì su quello collocato accanto. Una assoluta nullità, dunque.[1].
Un’assoluta nullità, dunque. E invece ecco che mi viene incontro un personaggio completamente diverso: un conversatore brillante e loquace, bugiardo e battagliero, lucido e vendicativo, uno che manifesta una insolita esperienza della vita, e degli uomini, e delle donne, e che in modo apparentemente casuale si prende i suoi piaceri e le sue rivincite[2].
Mi sono subito chiesto se il mondo, il nostro mondo videocratico e networkizzato, non sia diventato inetto e apatico a tal punto da farmi apparire un inetto d’altri tempi come un risoluto uomo d’azione. In fondo Zeno ci prova sempre ad agire. Discute con il medico del padre, si dichiara ad Ada, si trova un’amante. È inopportuno, sbaglia più volte bersaglio, d’accordo, crea comicità e imbarazzo, ma non è mai fermo, assente, muto. Zoppica, ma non è paralitico. Subisce delle sconfitte, ma non cessa mai di battersi.
Perché, allora, la diceria dell’inetto? Chi l’ha messa in giro?
Quando ho scoperto che Un inetto era il titolo che Svevo avrebbe voluto dare al suo primo romanzo[3] la risposta mi è parsa d’una semplicità quasi offensiva. È Zeno stesso l’artefice consapevole del mito della sua inettitudine. Il suo è il trionfo di un abilissimo seduttore. E dire che ci aveva messo in molte occasioni sull’avviso. Sin dall’inizio si era mostrato come un uomo soggiogato dai sensi e dal desiderio delle donne (l’ultima, dichiara candidamente dopo poche pagine, sarà l’infermiera al suo capezzale); aveva poi ammesso di conoscere la forza delle parole e della scrittura e sostenuto addirittura che le parole siano azioni[4], citando il fuoriclasse del genere: Jago[5]; in chiusura, infine, gli ultimi richiami li riserva a Da Ponte e Casanova. I suoi punti cardinali sono i maestri della lusinga e dell’inganno[6]. E già tanta competenza suonerebbe strana in chi vuol farsi credere maldestro e pasticcione. Ma ancora di più stona con la sua leggenda l’esito finale degli eventi: il suo matrimonio è l’unico del libro che riesce. La moglie lo circonda di un mondo sano e regolato e Zeno diventa un patriarca. Le sue scelte accidentali si dimostrano alla fine le più convenienti e vantaggiose, a cominciare proprio dalla moglie. Merito solo del caso?
Tu leggi e a un certo punto ti viene il dubbio. E se davvero ci stesse gabbando con la storia della malattia e della dappocaggine? Quale verità nasconde dietro la sua inesauribile destrezza affabulatoria? È davvero “così privo di volontà”, come dice di essere[7] e come vorrebbe il primo principio di un decalogo dell’inettitudine? La malattia non è forse la sua più geniale ed elegante trovata per non assumersi alcuna responsabilità?
“La salute – scrive limpidamente – spinge all’attività e ad addossarsi un mondo di seccature”. È manifesto che Zeno non voglia essere molestato dai tanti fastidi della vita quotidiana: cerca sempre di schivare ciò che lo importuna, finanche i bambini, con i quali non è pietoso né comprensivo. E in un’occasione confessa: “finsi quella malattia che doveva darmi la facoltà di fare senza colpa tutto quello che mi piaceva”[8]. È il suo trucco, per sfuggire alla usuale dialettica tra pensiero e azione, delitto e castigo, e giustificare la sua capacità di adattamento a ogni evenienza e a ogni smacco[9]. Quando non riesce a indirizzare le cose secondo il suo desiderio, si esonera da qualsiasi adempimento, si affida alla corrente, lascia che la vita decida per lui, ma per scelta, volontariamente. Decide di non decidere[10]. Una strategia, ma degna di un generale, non di un inetto.
Se lo si osserva più da vicino e non si dà credito alla sua eloquenza, ci si accorge poi che Zeno ride e deride, è attento, non ripete gli errori, come quando non entra nella stanza del suo amico Copler per dargli l’estremo saluto perché troppi moribondi lo avevano già guardato con rimprovero. Vede con chiarezza i difetti e le debolezze degli altri. Anche negli affari. Sa affrontare e chiudere bilanci commerciali, non si rovina in borsa e nell’ufficio sovrasta gli altri. Si dice forte e ha fortuna, e in ultimo trionfa nel commercio.
A suo modo, è determinato e coraggioso, smaliziato e riflessivo. Si liquida dell’amante con un’invenzione che sarà carica di conseguenze: con il solito gusto del fraintendimento, le indica Ada come sua moglie. Ma più che fingere, Zeno si mette sempre in condizione di non doverlo fare. Sa dissimulare e parlare per metafore. Non riesce a ristabilire la verità e a provare la sua innocenza, ma dentro di sé la riconosce. Si sente intero, anche se ridotto in un silenzio impotente di fronte a rimproveri ingiusti. Ha una natura barocca e in più occasioni dimostra una filosofica saggezza: conosce “l’assurda e amara originalità della vita in cui l’uomo è un errore”[11]. Conserva tuttavia un fondo di ottimismo. In ultimo si dice guarito e sano e soddisfatto della sua vita. Il suo monologo si conclude con una sarcastica confidenza: “Naturalmente io non sono un ingenuo.”[12]
Ma cosa lo muove? Quale è il motore della sua impostura?
Ciò che Zeno si ostina a negare o a ricoprire con i suoi infiniti discorsi, si traduce presto nel lettore diffidente in un sospetto banale ma assai verosimile. Il suo movente è un desiderio di rivalsa.
Il tema del fumo ha il compito di sollevare una vera e propria cortina di vapore intorno ai veri sentimenti di Zeno, si fa allegoria di un uso dilatato del linguaggio, digressivo capriccioso inquinante, è il gioco di un illusionista provocatoriamente reoconfesso, seppure con estro raffinato ed enigmistico. La scelta dell’elemento “fumo” come primo capitolo è già carica di risonanze, ma ancora di più l’ossessiva datazione dell’ultima sigaretta rivela una memoria rancorosa, un senso ritorto del tempo, un calendario interiore di lacerazioni e offese.
Il tempo, per Zeno, è una ferita continua.
La ragione di tanto malanimo, di tale dolorante rapporto con la realtà, Zeno stesso la ravvisa nella mancata stima che ha di lui il padre, nella negligenza del loro affetto.
Come Pinocchio, La coscienza è l’altro libro della nostra letteratura privo della figura della madre, un libro tutto di scontri e di comparazioni tra uomini. Con il padre, innanzitutto. Poi con l’altra variante paterna, il suocero, il signor Malfenti. Infine, con il cognato, Guido, l’antagonista, il giovane di fascino, ingegno e belle speranze che sposerà Ada e con il quale, a distanza di molti anni, Zeno vincerà il confronto, senza riserve e agli occhi di tutte le donne[13]. Ma, a differenza di Pinocchio, negli uomini che circondano Zeno non c’è né tenerezza né amore. Il suo è, se possibile, un universo ancora più agro, senza mastri Geppetti e candele steariche tenute accese nel buio di un sottosuolo o nella pancia di un pescecane. Si chiarisce allora che l’inettitudine di Zeno può avere valore nella sola accezione di un disadattamento cronico, di un’insufficienza affettiva. Zeno è in guerra con il mondo, ma è dotato di una pazienza orientale. Si siede sulla riva del fiume e aspetta i cadaveri dei suoi nemici. Ha la grande abilità di rovesciare sempre i suoi limiti in virtù e le umiliazioni in successi. Esemplare la faccenda del violino, l’arma vincente di Guido agli occhi di Ada. Nonostante il superiore e indiscutibile talento del cognato, alle lunghe Ada finirà per odiarne il suono. Augusta, invece, la terza sorella, la scelta di ripiego, si manifesterà ancora una volta una compagna salda ed entusiasta, restando beata ad ascoltare Zeno ogni qual volta ne avesse voglia, nonostante la sua mediocrità di musicista.
È una delle sue rivincite. Tutte le promesse di Guido di riuscire nella vita si corrompono rapidamente. Passaggio dopo passaggio, nel dettagliato resoconto di Zeno, Guido si svelerà furbo, spregevole, avventato, senza scrupoli, incapace, all’opposto di lui, di portare avanti una relazione con la segretaria senza compromettere il suo matrimonio. Zeno assiste al progressivo avverarsi della sua tragedia concedendosi persino la magnanimità dell’amicizia e del sostegno.
Il racconto della morte di Guido è il culmine del libro. Nell’inscenarsi di una spaventosa congiura delle circostanze, l’episodio ha un suo ritmo shakesperiano. Ma la trama borghese di una rovina finanziaria, filtrata dalla sua voce, si tramuta in una vicenda infinitamente più complessa e, in definitiva, in una questione privata. Zeno assiste alla commedia della morte, ai rimpianti e ai rimorsi che provoca, ma non ne prende parte, anzi ne sfida il potere purificatore. Da vero funambolo dell’equivoco, forza al massimo l’ambivalenza della realtà e attraverso una serie incredibile di malintesi si sottrae al funerale del cognato, in una delle sequenze più famose e comiche del romanzo, sbagliando corteo. Poi, in un lusso di autodifesa, di sfida e volontà di ripristino, vince in borsa per conto dell’“amico” morto, ma, anche in questo caso, temperando sia l’ira che la bramosia.
È l’accordo centrale della sua lunga confessione.
Se non si presta fede agli scherzi del caso e ai suoi aneddoti coloriti e si accetta di seguire la pista della non accidentalità degli accadimenti attraverso i quali si dipana la sua esistenza, tutto assume ben altro significato.
Ada è l’Elena del libro, la regina che lo ha rifiutato, e anche verso di lei si indirizza l’infantile e feroce necessità di rivalsa di Zeno. Ada invecchia, si ammala di un morbo terribile, perde la sua bellezza, viene umiliata dal marito, sa d’essere tradita. Il suo destino di infelicità si compie secondo una meccanica esatta e crudele. Fino alla resa, all’ammissione privata dell’errore e all’amarezza del rimorso. Fino al riconoscimento straziato a Zeno, nella penombra di casa Malfenti, d’essere lui il miglior uomo della famiglia, il maschio più forte del gruppo (e l’elogio suona di risarcimento e riscatto, oltre che verso Guido, anche e soprattutto verso il padre e il suocero che non lo hanno mai valutato abbastanza).
C’è una ferinità verghiana[14] celata magistralmente in questo libro, un inventario di furori segreti, una lotta mortale. Zeno è più simile alla lupa delle novelle rusticane o, semmai, a un implacabile conte di Montecristo che al decadente modello dell’inetto novecentesco in cui è riconosciuto. La sua non è una moderna favola volteriana, ma l’antica commedia delle maschere. Zeno non è e non sarà mai un Candide che attraversa la realtà chaplinianamente, come vuole farci credere. L’inettitudine è solo il suo cavallo di legno, l’inganno col quale vincere la competizione dell’esistenza. Zeno è un ulisside travestito da mendicante e da buonoanulla. La sua è una terribile storia di vendetta e di affermazione e di irriverente scherno a tutte le convenzioni borghesi. Uno dopo l’altro, Zeno si burla dell’obbligatorio rispetto del padre, dell’istituto del matrimonio, dell’illusione dell’amore e dell’amicizia, della pratica dell’accumulazione capitalistica e della guerra e persino della cerimonia del lutto e dell’ipocrisia della morte. In un microcosmo familiare dove i nomi di tutti cominciano per A (Ada, Alberta, Augusta, i figli Alfio e Antonia), il suo, per Z, è un’anomalia, una capriola, uno sberleffo. La prova di una consapevole identità, agli antipodi della norma. Un segno di disubbidienza e di stravaganza, di ribaltamento del mondo e delle sue leggi, e dei suoi alfabeti.
NOTE
[1] Musatti spiega poi il processo umoristico usato da Svevo per convogliare simpatia e solidarietà su Zeno: un personaggio che si scopre e denuda per tutti gli aspetti deteriori della sua umanità rende superflua l’aggressività critica del pubblico e si riscatta. “Con questo mezzo il personaggio umoristico si conquista l’affettuosa comprensione del lettore, che con lui solidarizza e s’identifica, perché le debolezze di lui si rivelano debolezze di tutti.” Per Musatti, la coscienza del titolo è la coscienza di Zeno delle proprie deficienze e miserie. (“Belfagor”, marzo 1974).
[2] Ripercorrendo l’avventura critica del romanzo, a lungo si discusse dell’identificazione tra Zeno e Svevo, esercizio per alcuni arbitrtario e sterile. Di qualche interesse, tuttavia, questo breve e antiretorico ritratto che fece dello scrittore triestino il suo amico Bobi Bazlen e che potrebbe essere esteso anche a Zeno: “Non aveva che genio: nient’altro. Del resto era stupido, egoista, opportunista, gauche, calcolatore, senza tatto. Non aveva che genio, ed è questo che mi rende più affascinante il suo ricordo” (La morte di Italo Svevo: ultimo addio, in “La Fiera Letteraria”, 23 settembre 1928, ora in I. Svevo, Carteggio con J. Joyce, E. Montale, V. Larbaud, B. Crémieux, M.A.Comnène, V. Jahier, a cura di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 1978, pp. 94-98).
[3] Fu cambiato in Una vita in seguito al rifiuto di Emilio Treves di pubblicare un romanzo “con un titolo simile”.
[4] Così scrive Guido Guglielmi: “Le parole non sono per l’appunto azioni, non mirano all’esterno a provocare modificazioni della realtà ma hanno in sé il loro proprio premio, sono modi di realizzazioni e di compensazioni simboliche, non mirano alle cose ma le sostituiscono. […] La parola sana Zeno e lo riequilibra: dietro di essa egli può schermirsi e preservarsi.” (La narrazione dell’ultimo Svevo in “Tempo presente”, giugno 1961, ora in Glosse a Svevo in Letteratura come sistema e come funzione, Torino, Einaudi, 1967, pp. 104-7).
[5] “(…) so benissimo che le parole di Jago, per esempio, sono delle vere e proprie azioni” in Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Gruppo editoriale l’Espresso, divisione La repubblica, 2002, p. 262.
[6] Ha rilevato con efficacia Mario Lavagetto che “l’autentico oggetto del discorso narrativo” della Coscienza di Zeno non sono gli episodi della vita del protagonista ma è “un vecchio – più precisamente un vecchio bugiardo – che prende la parola e scrive con un destinatario preciso – lo psicanalista a cui si è rivolto – da circuire e da ingannare. Un vecchio bugiardo che scrive, dunque. Non credo che questo enunciato, nella sua povera banalità, possa suscitare resistenze o trovare oppositori. Ma credo tuttavia che questo enunciato, se tenuto ben fermo davanti agli occhi, generi tutta una serie di tesi e di corollari, che hanno nel loro insieme un’evidenza assoluta”. Non bisogna mai dimenticare, per Lavagetto, che questo racconto è il racconto di una narrazione e che qui è il motore della macchina narrativa di Svevo. (Correzioni su Zeno, in Italo Svevo oggi. Atti del convegno, Firenze 3-4 febbraio 1979, a cura di Marco Marchi, Firenze, Vallecchi, 1980, pp. 131-140.) Secondo l’insegnamento di Henry James, aggiunge Lavagetto, bisogna leggere anche questo romanzo come un “esercizio di omissioni” (H. James, Le prefazioni, Milano, Lerici, 1958, p. 41).
[7] Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cit., p. 183.
[8] Ivi, p. 185.
[9] Giacomo Debenedetti ha individuato una sensibilità e un tono tipicamente ebraico nell’opera di Svevo e in Zeno: “l’instabile molteplicità del fondo morale lo renderebbe [l’ebreo] plastico, disponibile e deformabile a tutti gli urti” (Omaggio a Italo Svevo, in “Il Convegno”, gennaio-febbraio 1929, ora in G. Debenedetti, Saggi 1922-1966, a cura di F. Contorbia, Milano, Mondadori, 1982, pp. 248-252).
[10] Per Guido Guglielmi “Zeno è alienato nelle cose; si attende dall’esterno quello che non può operare sé, ha abdicato al suo potere di decisione spostandolo all’esterno, trasferisce all’‘altro’ le sue potenzialità investendone l’oggettività. E la sua è una vita indiretta.” (La narrazione dell’ultimo Svevo, cit.).
[11] I. Svevo, La coscienza di Zeno, cit., p. 292.
[12] Ivi, p. 382.
[13] Giuseppe Prezzolini, tra i primi a capire il valore del romanzo, denunciò subito, senza dubbi, l’odio di Zeno per il cognato (Rivelazioni: Italo Svevo, in “L’Ambrosiano”, 8 febbraio 1926); Vittorini parlò invece dell’”elegante freddezza” con cui Zeno esamina le cose dalla distanza degli anni, “in una luce quasi clinica” (Diario in pubblico. Parte prima: 1929-1936. La ragione letteraria, 2. ed., Milano, Bompiani 1970, pp. 13-19); Claudio Magris e Amgelo Ara definiranno “accidiosa” l’immaginazione dei personaggi di Svevo (Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982, pp. 40-46); Debenedetti, sviluppando il suo discorso sul fondo ebraico dell’anima di Zeno, fissa il fuoco sulla sua “implacabilità”, su “un gusto della ritorsione che ricordano l’appassionata ferocia dell’antisemitismo semita” (Omaggio a Italo Svevo, cit.).
[14] Scrive Montale: “Come poeta della nostra borghesia – poeta giudicante e distruttivo – si può considerare Svevo un continuatore di Verga” (E. Montale, Italo Svevo nel centenario della nascita (1963), ora in I. Svevo, Carteggio, cit., p. 143).